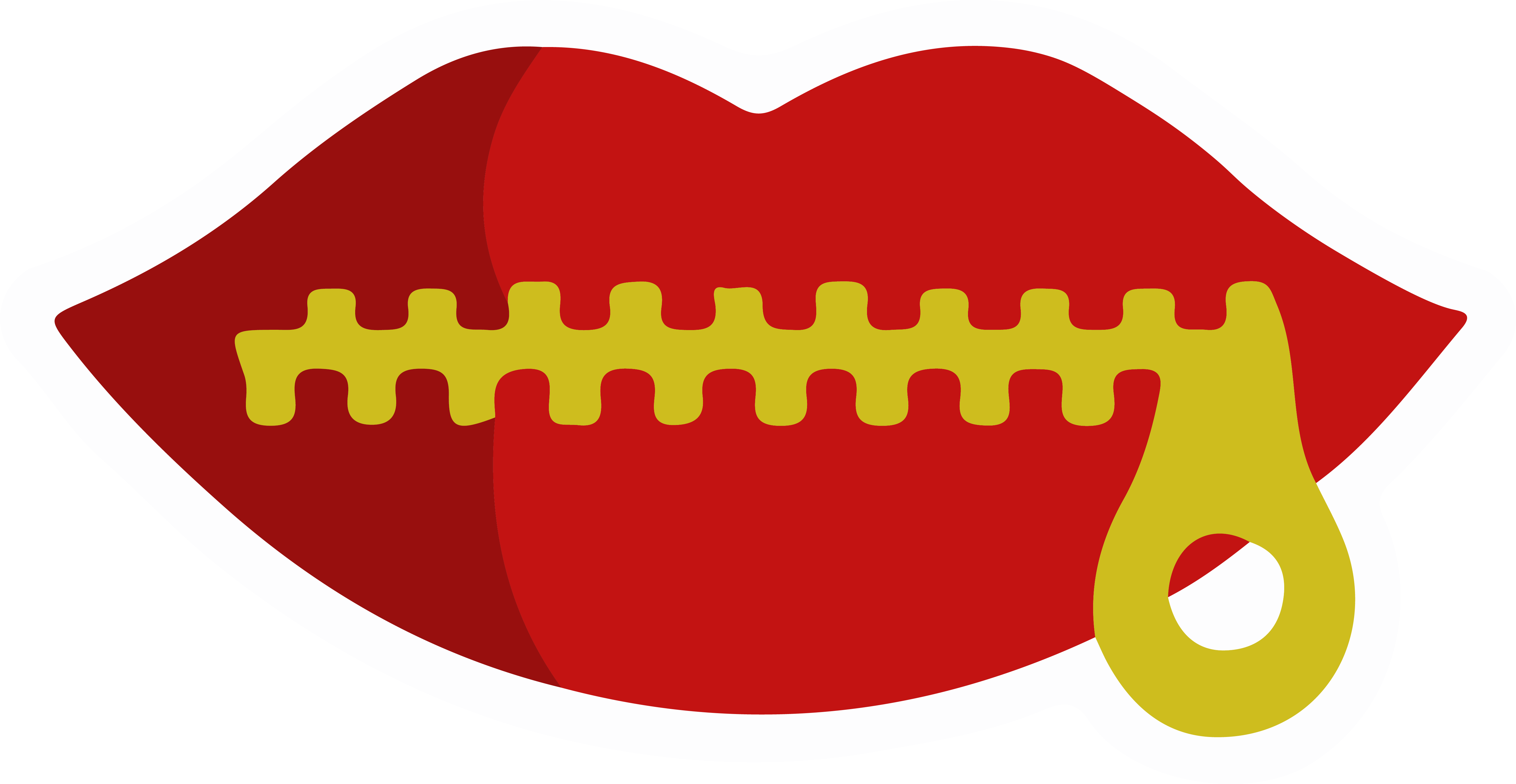In Mask Girl, la protagonista viene perseguitata da una donna che cucina sempre i famosi gnocchi di riso piccanti (tteokbokki): è un esempio di street food comunissimo, ma ha forse un significato? Rosso, piccante, eccessivo. Una vecchina carina e insospettabile in realtà nasconde una volontà di vendetta omicida folle. Come quando guardi i tteokbokki e ti chiedi: quanto mai potranno essere piccanti?
Ecco: questo è il cibo asiatico che racconta le sue verità. Corpi che mentono versus piatti che non ci riescono.
In molte serie coreane (ma anche giapponesi e cinesi), il gusto è narrazione. In Link: Eat, Love, Kill, il protagonista è legato telepaticamente a una donna di cui sente emozioni e dolori, ma la vera intimità nasce mentre cucina per lei. Ogni piatto diventa confessione, consolazione, presenza. Non è mai solo fame. È lutto, amore, paura, colpa. E ogni cosa si dice con il brodo.
Il cibo è la trama
Nel mondo asiatico il cibo non è il contorno della trama: è la trama stessa.
E spesso, ha un sapore che all’Occidente non va giù.
Perché il problema del gusto asiatico, per chi ci arriva da qui, non è la diversità. È la sincerità.
Noi siamo gente da piatti concilianti. Pasta, mozzarella, crema pasticcera: il gusto “buono” è sempre liscio come una carezza, avvolgente come una coccola. Lo chiamiamo comfort food.
Ed è bellissimo. È cura. È memoria dei nonni, delle domeniche, della tavola come tempio.
Nessuna ironia: c’è un’arte tutta europea nel rendere il cibo rifugio. Ma non possiamo pensare che questa sia l’unica verità del gusto.
Perché il cibo asiatico, spesso, ti sbatte addosso la realtà. Ti dice: “Non sono qui per coccolarti. Ti sto mostrando chi sono.”
Adesso è tutto umami?
Hai presente l’umami? Quella parola che ora tutti mettono ovunque – umami burger, umami experience, umami candle se esiste.
In Giappone non è un trend. È un gusto codificato, riconosciuto scientificamente nel 1908 da Kikunae Ikeda, e da sempre incluso nella percezione sensoriale alimentare orientale. Ma l’umami non è solo “buono”, è profondo. È l’eco sapida del mondo che resta in bocca: il kombu bollito, il miso non filtrato, il bonito che ti gratta l’anima. Cose che a molti in Occidente in realtà farebbero schifo: mica è solo sushi a e s t h e t i c.
È memoria, fermentazione, tempo. Non ha fretta di piacerti. Ha fretta di dirti qualcosa.

L’amarezza cinese
Lo stesso vale per il concetto cinese di 苦 (kǔ), il “gusto amaro”. Che non è solo sapore, ma condizione dell’anima.
In Cina si dice “吃苦” (chīkǔ) — mangiare l’amaro — per dire che hai sopportato, che sei passato attraverso il dolore con disciplina. In Corea si cucina il gosari namul, felce saltata, un vegetale amaro che viene servito come conforto.
Il gusto qui è esperienza esistenziale. Non è il premio alla fine. È il cammino.
E noi cosa facciamo? Ci fermiamo al “puzza”, “è strano”, “ma davvero mangiano questa roba?”.
Come se il nostro gusto fosse universale e gli altri fossero solo variazioni folkloristiche.
Come se il nostro “buono” fosse il centro del mondo.
Ma chi siamo “noi” e “loro”?
È vero, anche dall’altra parte si può dire che ci sia il pregiudizio che il nostro cibo sia grasso e oleoso: non fa ridere? Anche per noi “il cinese” è il “fritto”, “pesante”, “all you can eat”, “bassa qualità”. E invece è ciò che “loro” pensano piaccia a “noi”.
C’è un termine giapponese che adoro: natsukashii (懐かしい). È la nostalgia dolce per qualcosa che ti è rimasto impresso, anche se non lo capivi del tutto. Un sapore può essere così. Può evocare un’altra lingua, un altro ritmo del mondo. Ma solo se sei disposto a non capirlo subito. Solo se non ti difendi.
Che poi se ci pensiamo, da dove nasce il gusto? È una questione di abitudine, di cultura, di affinità; ma è anche qualcosa di politico, coloniale, educato, costruito.
Ci sono schemi e mentalità, tradizioni e vendette, rigetti e assimilazioni: il sapore rivela chi siamo più di quanto riusciamo a renderci conto, forse. Se accettiamo di provare qualcosa di diverso, forse saremo più inclini a sopportare il cambiamento che talvolta ci spaventa.
E non dico che “noi occidentali” sbagliamo o dobbiamo rivedere il nostro cibo: la scoperta, la sperimentazione, sono sempre dei passi positivi nel conoscere noi stessi oltre che il mondo esterno. Capire cosa si mangia, fa comprendere di più noi stessi e un’altra cultura. Dovrebbero farlo anche gli altri? Certo, ma iniziamo sempre con il buon esempio.
Allora la prossima volta che ti trovi davanti un piatto di natto, kimchi stagionato o fegato brasato con zenzero, non chiederti se ti piace.
Chiediti: cosa mi sta raccontando questo sapore che non volevo sentire?
E se la risposta è “non so”, allora forse è lì che inizia il vero gusto.
Quello che non consola. Quello che risveglia.
di Alessandra “Furibionda” Zanetti