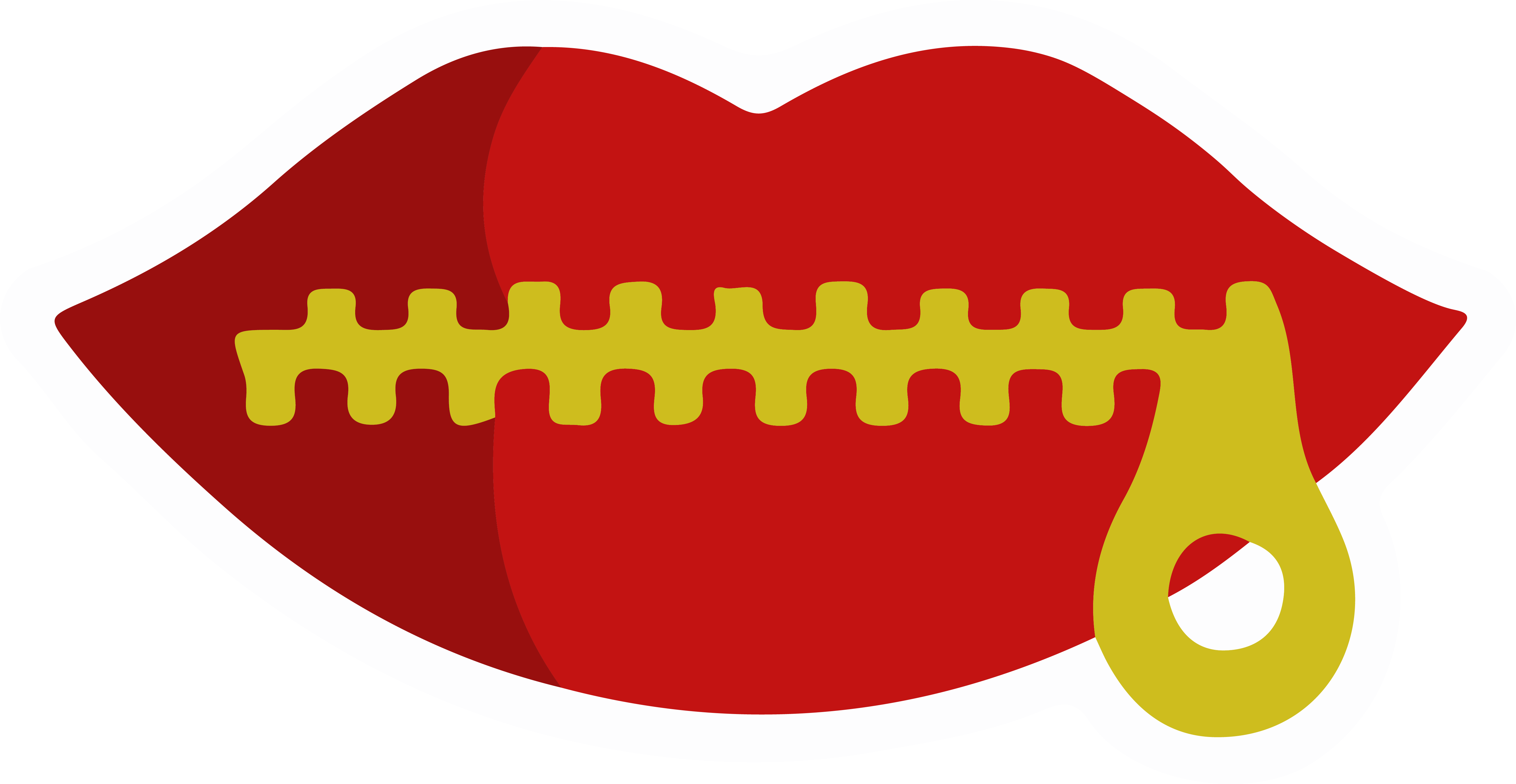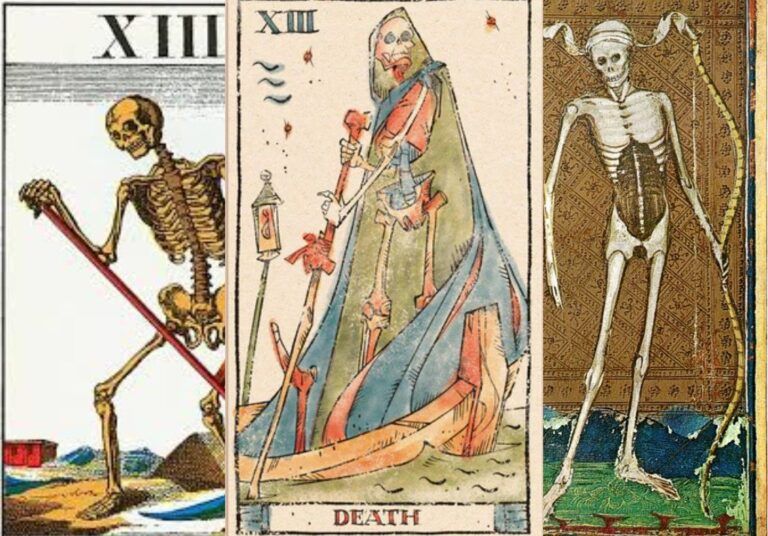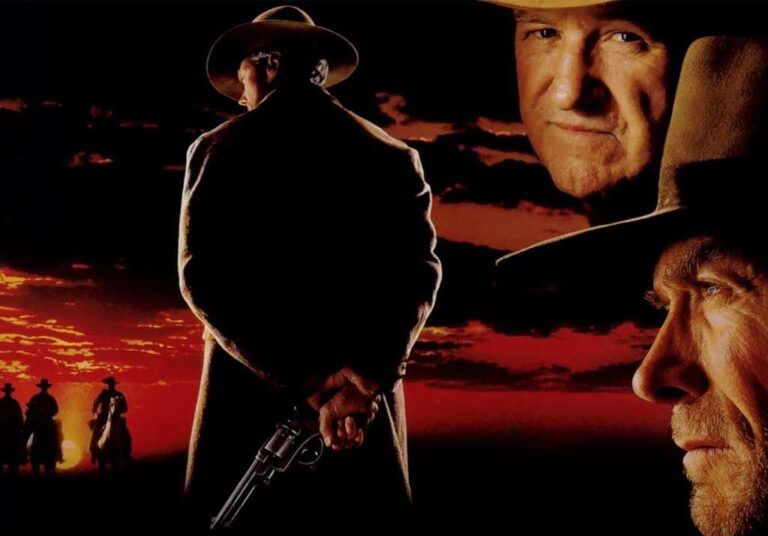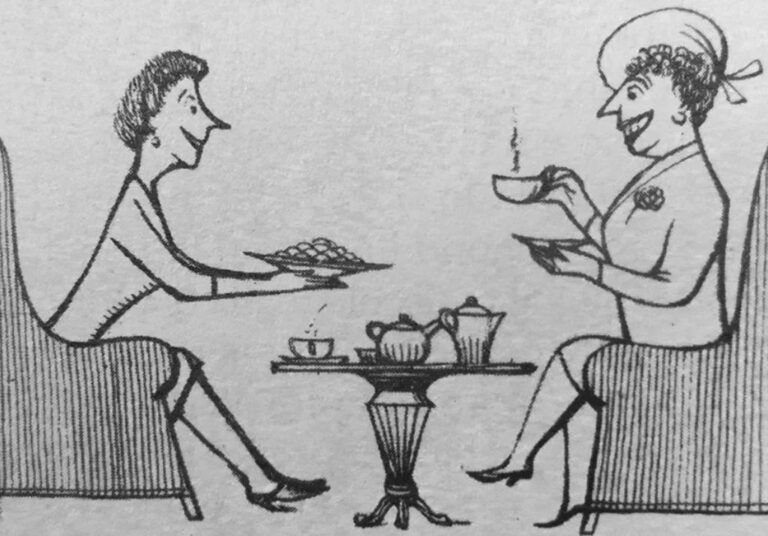Sul palco di un teatro la gente muore spesso e volentieri. Muore di malattie incurabili, a seguito di esecuzioni capitali, muore avvelenata, assassinata o vittima di vendette fratricide. Oppure muore di follia, di stenti o togliendosi la vita in modi più o meno discutibili.
Non potrete trovare niente di tutto questo in archivi e notizie di cronaca nera, poiché parliamo di finzione, recitazione, fatti che si ripetono uguali ogni sera per far vivere (e morire) le storie più amate dagli assidui frequentatori degli spettacoli di Opera lirica.
Al pubblico piace conoscere il finale
Succede praticamente sempre che il pubblico dell’Opera vada a teatro perfettamente consapevole di come andrà la storia rappresentata. Per noi poveri teatranti è una terribile fonte di stress: molti di loro non si limitano a sapere tutto della vicenda ma ricordano nota per nota non solo parole e musica ma anche come i grandi interpreti del passato ebbero apportato modifiche in ogni dove a loro gusto, diverse volta per volta e di registrazione in registrazione.
Li trovi poi dietro le quinte, questi grandi appassionati, si intrufolano e sgusciano in aree a loro normalmente inaccessibili per farti le pulci sulla tua sudata interpretazione. Si avvicinano sorridenti e partono con l’interrogatorio: “Perché hai tenuto quella nota così corta?”, “Perché non hai cantato quell’acuto?”, “Non potevi cantare più forte in quel concertato?”, “Non ho mai sentito quelle parole, hai sbagliato?”, “Ti sento poco appassionato stasera, stai male?”, “Non hai mai pensato che questo ruolo fosse un po’ troppo per te?”, e così via discorrendo in un fiume di critiche e aspettative deluse.
A voler vedere il bicchiere mezzo pieno, un pubblico così esigente non ci permette, quando le cose vanno bene, di adagiarci sugli allori e ci spinge, non senza fatica e frustrazione, a fare sempre del nostro meglio, terrorizzati dai temutissimi buu e fischi che potrebbero precipitare dal loggione.
Il masochismo del melomane
Pare evidente che ai melomani (così vengono definiti questi “maniaci del melodramma”) piaccia soffrire. In primis patiscono sofferenze nostalgiche, cast e interpreti non sono all’altezza dei divi del loro pantheon operistico, mentre registi, scenografi e costumisti fanno di tutto per tradire storie e libretti a loro sacri (ma questa è un’altra storia…). In secundis adorano le disperate tragedie di cui le opere sono piene zeppe.
Questa è passione vera: in queste storie tragiche e strappalacrime in cui puntualmente i nostri eroi ci lasciano le penne, i melomani sanno tutto, sanno che sarà uno spettacolo tristissimo e che soffriranno terribilmente, e cosa fanno? Vanno a teatro a soffrire e ci ritornano, ancora, e ancora, e ancora.
Stesse storie, stessi tormenti, stessi personaggi che vivono, amano, soffrono, cadono vittime del loro destino, cantano ancora un po’ e finalmente tirano le cuoia per davvero, prima che qualche collega chiuda definitivamente la questione con un sonoro “È spenta!”, o “È in cielo”, o ancora “In terra più non è!”.
A questo punto per noi sul palco la sfida si fa ardua. Dobbiamo essere credibili in tutto, ma chi ci spiega come morire bene?
Le convenzioni della morte
Quello dell’Opera è un linguaggio artistico piuttosto lontano da teatro e cinema odierni, dove siamo oggi abituati a rappresentazioni che rispecchiano spesso avvenimenti e relazioni tra i personaggi in maniera il più realistica possibile.
Il Melodramma possiede invece degli stilemi che rendono tutto molto più astratto e irreale, primo fra tutti la musica. Il ritmo della narrazione, la messa in scena dei sentimenti, la dilatazione o contrazione temporale delle azioni sono tutte in funzione della guida emotiva dettata da svolgimento e sviluppo musicale.
Si tratta di vere e proprie convenzioni sceniche, che ad ogni modo (e per fortuna) sono andate sviluppandosi e adattandosi ai gusti di ogni epoca col passare dei decenni, cambiando gradualmente con loro.
Uno di questi tanti aspetti maggiormente soggetti a convenzioni e rappresentazioni simboliche è la morte di un personaggio. Così come quando, in preda a passioni amorose o spiriti bellicosi, il nostro eroe canta lunghissime arie e cabalette, che altro non fanno che presentare e confermare pensieri e stati d’animo, allo stesso modo viene trattato il momento della dipartita.
Dopo l’avvenimento chiave che dà corso agli eventi fatali, come una coltellata, uno sparo o una goccia di troppo di veleno, abbiamo bisogno che la vittima ci racconti cantando, e spesso cantando a lungo, quanto è triste morire, o quanto sarà meraviglioso l’al di là che già intravede, o come la giustizia alla fine ha trionfato o trionferà sul mondo dei vivi e su quello dei morti.
Detto in poche parole, chi è lì lì per schiattare spesso ci propina dei pesantissimi sermoni musicali che altro non fanno che ritardare la fine dello spettacolo in maniera tutt’altro che necessaria o richiesta. Niente di tutto questo è d’aiuto ad una rappresentazione efficace della morte.
Sempre uguale e sempre diversa
Non esiste un solo modo di morire in scena. Le storie sono innumerevoli e spesso molto diverse, anche se alcune prediligono certi tipi di morte: tubercolosi (grande classico), accoltellamenti, suicidi, avvelenamenti e fatali perdite delle facoltà cerebrali sembrano andare per la maggiore. Può però capitare di tutto, il limite è la fantasia di compositori e autori dei libretti, per cui noi che saliamo sul palco siamo pronti a qualsiasi evenienza.
Tuttavia, anche interpretare gli stessi personaggi in continuazione non significa affatto che questi si trovino ad affrontare le stesse esatte situazioni e circostanze. Non è neanche detto che chi alla fine della storia di solito sopravvive arrivi ad incontrare sempre lo stesso destino: secondo il livello di reinterpretazione degli avvenimenti, ci si può trovare in contesti totalmente capovolti per un’infinità di motivi diversi. Insomma: ogni volta ci si può trovare davanti a tutta un’altra storia.
Succede quindi che a volte, anziché i soliti trapassi evergreen, ci si trovi catapultati nello spazio a soffocare in assenza di ossigeno, oppure protagonisti già deceduti di visioni del passato, spettri in comunicazione dall’altro mondo, sovrani che morendo si alzano in volo e chi più ne ha più ne metta. Non ci si annoia mai, per cui dobbiamo essere a nostra volta molto fantasiosi e sapere come riadattare le nostre idee al servizio di quanto avviene in scena.
Lo schema è comunque simile: prima si cerca di entrare in sintonia con l’idea teatrale del regista, la quantità di realismo richiesto e il contesto in cui si inseriscono gli ultimi istanti del personaggio. Poi si mette tutto in relazione alla quantità e difficoltà della musica da dover ancora cantare e si tiene duro fino all’esalazione dell’ultimo respiro, che di solito coincide col finale dello spettacolo.
La morte degli altri
Altrettanto complesso è il ruolo di chi invece assiste alla morte di qualcun altro. Spesso si tratta di personaggi molto legati tra loro, come amanti o parenti stretti, per cui via libera a disperazione e tragedia personale. Qua si lavora di anticipo, avendo spesso il tempo di sviluppare il tutto in diverse fasi.
Si parte da un momento di consapevolezza della imminente dipartita altrui, per cui si inizia a lavorare sul pianto e sulla tristezza. Mentre pensi alle cose tristissime come le tasse, Schindler’s List o la pizza con l’ananas, cerchi di aumentare il ritmo della respirazione, guardare fisso qualche luce di scena ed evitare di sbattere le palpebre. Con un po’ di fortuna, facendo così inizierai a sentire delle lacrime spuntare lentamente dagli occhi in fiamme. Se così non fosse, farai finta di piangere rumorosamente tra una frase cantata e l’altra del tuo collega, così ti si sentirà adeguatamente senza che tu copra la sua voce. La distanza dal pubblico creerà l’illusione perfetta.
Se non sarai già a contatto ravvicinato col partner musicale, con molta probabilità dovrai preparare le cose perché l’altro possa, moribondo, appoggiarsi alla tua solida figura destinata a restare nel regno dei vivi. Starete in posizioni innaturalmente contorte, così da poter cantare entrambi verso il pubblico, e terribilmente scomodi, ma sarai tu a dover fare in modo che il collega morente sia nella posizione ideale allo spiegamento della voce senza intoppi. Metti al sicuro i tuoi piedi, se te li pesta è la fine.
Attento alla postura.
Probabilmente dovrai sorreggerlo, cantare, recitare e resistere per diversi minuti. Mettiti dritto in anticipo, correggere il tiro mentre siete in terra sarà quasi impossibile, schiena e ginocchia ne soffriranno per cui sii pronto e cerca di non farti venire qualche crampo.
E soprattutto canta bene, vai a tempo, sii passionale, canta come i grandi artisti del passato, ma non fare cose troppo desuete come facevano loro, controllati ma lasciati andare, emozionati e fai emozionare, e ricorda di offrire cena e biglietti alle persone giuste che potranno aiutarti nella carriera.
Fai morire bene gli altri, muori bene quando tocca a te.
La verità…
… è quello che vorrebbero vedere tutti dal pubblico e trovare tutti sul palco. Seppur nella simbolicità e astrazione delle convenzioni operistiche, chi ci tiene davvero dà molta importanza, tra le tante cose, alla rappresentazione della morte. Così, come per ogni cosa in teatro, è necessario uno sforzo di immaginazione non indifferente per veicolare gesti ed emozioni in maniera concreta e convincente, nonostante tutte le varianti e tutti gli imprevisti del caso.
Una risorsa utile in questo caso è qualcosa da cui nessuno vorrebbe poter attingere: l’esperienza personale. Nella nostra vita da girovaghi il tema del lutto è uno dei più delicati, si impara molto presto a capire il peso dell’assenza, si capisce l’importanza dell’essere presenti nel momento dell’addio e si porta il peso del rimpianto quando invece non è possibile. La gioia di poter portare ad altri le emozioni di una grande storia passa a volte dalle sofferenze che in silenzio portiamo dentro.
La vita sul palcoscenico ci toglie tanto…
…ma ci dà anche l’opportunità di liberare una parte di noi stessi e dei nostri dolori mettendoli al servizio di qualcosa di meraviglioso. Non sempre, ma a volte quel poco di morte che abbiamo nel cuore riusciamo a trasformarlo e usarlo per far vivere un’emozione in tante persone diverse. E la morte è esorcizzata e tenuta lontana, ancora per un altro po’.
Quando un giorno mia nonna se ne andò, e io dovetti salire sul palco la sera stessa, lei mi è venuta a trovare sul finale dell’opera. Le lacrime erano più realistiche, il peso dentro insostenibile, ma la mia performance non avrebbe potuto essere più vera.
Non ero riuscito a salutarla, per tanti motivi, ma lei era con me a prendere gli applausi tenendomi per mano, e con un bacio al cielo le ho potuto dire addio.