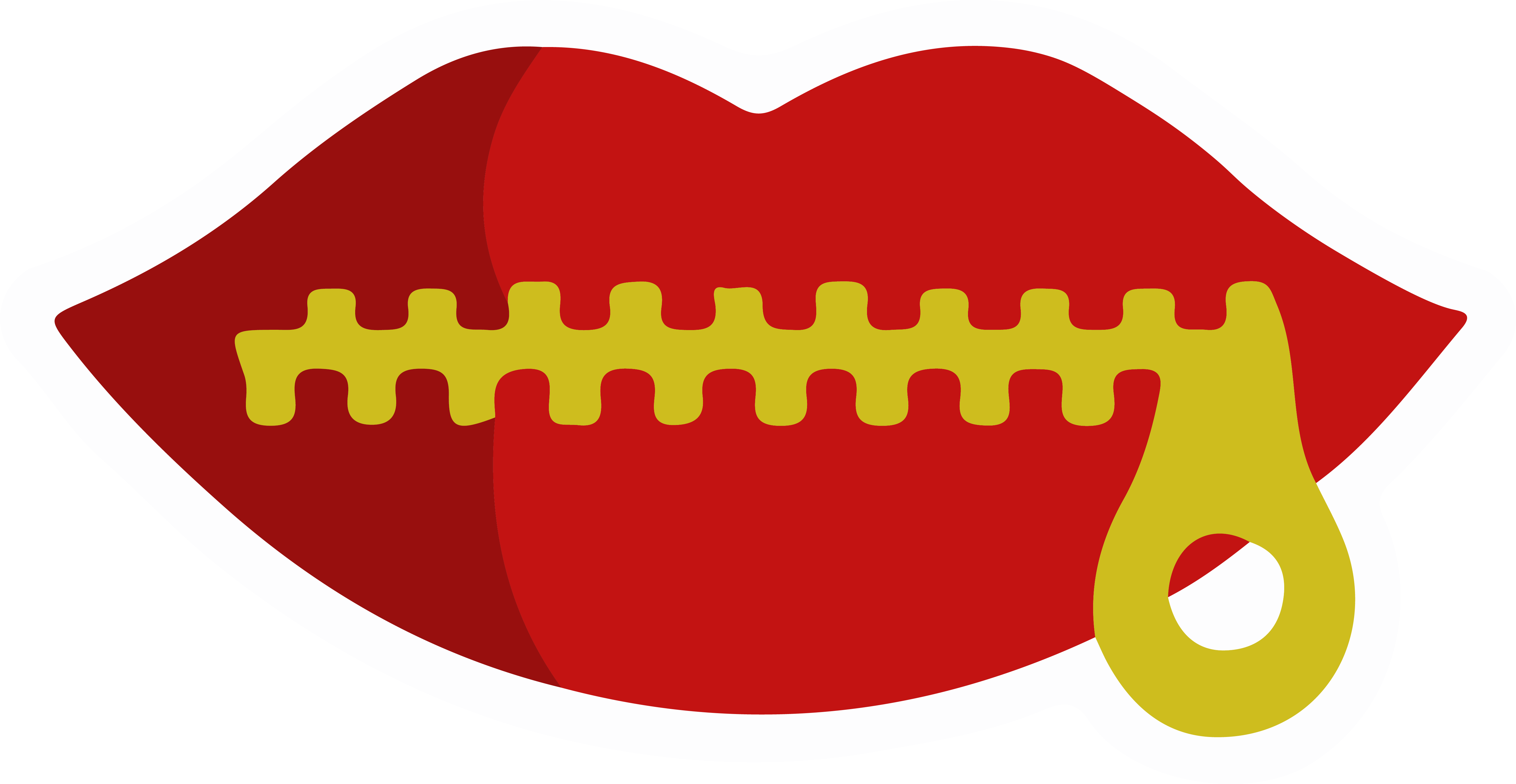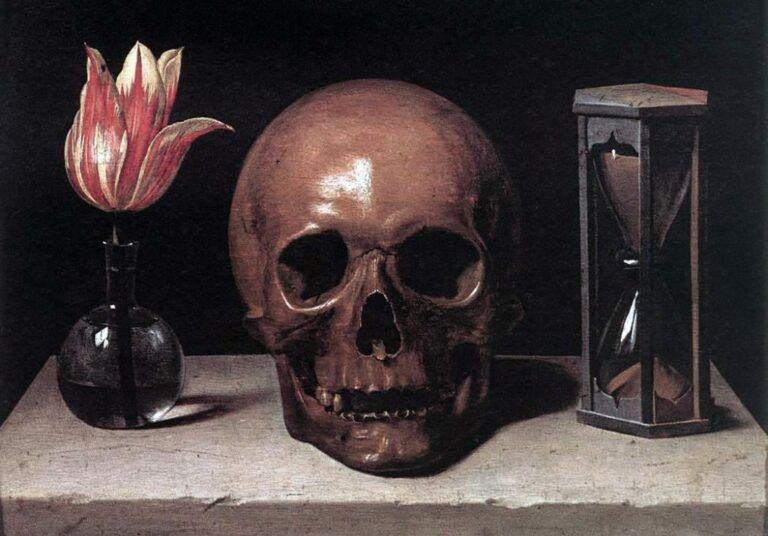Non mi ricordo più quanti anni avessi. Probabilmente dieci, sì, dieci. I miei nonni paterni vivevano in un casolare con un grande cortile — gigantesco, almeno per me — e dentro quel cortile c’erano dei conigli. Piccoli, bianchi, chiusi in una recinzione nera. Li ricordo benissimo. E, ovviamente, ogni tanto li mangiavamo.
Mia cugina, che era particolarmente sensibile, viveva ogni “sparizione” come una tragedia. Ogni volta bisognava raccontarle che i conigli erano scappati. Lei si arrabbiava, agitava le braccia, accusava i nonni di essere degli incapaci che non sapevano tenere i conigli in gabbia. Il giorno dopo, però, davanti a un piatto pieno di stufato, mangiava tranquilla. E tutti gli altri al tavolo ridacchiavano chiedendole com’era la pietanza.
Con me, invece, era diverso.
Mio padre preferiva la verità.
Ogni volta che un coniglio spariva, mi spiegava che era stato scuoiato, macellato e cucinato.
Un giorno mi portò in cucina, di nascosto. Mia nonna era lì, intenta a scuoiarne uno. Mio padre mi fece salire su uno sgabello, mi mise davanti il coniglio — ormai senza pelle, disteso su un tagliere — e mi disse: «Guarda».
Io guardai. Mi sono sempre fidato di mio padre.
Lui girò il coniglio, aprì la cassa toracica e tirò fuori i polmoni. Me li mostrò, mi spiegò a cosa servivano e, per dimostrarmelo, ci soffiò dentro: si gonfiarono come due palloncini rosa. Poi prese una zampa, tirò i tendini e mi fece vedere le dita che si chiudevano. Indicò i tendini sul mio polso e disse: «Vedi? Funziona uguale».
Probabilmente fu quello il momento in cui la mia vita prese una direzione precisa: potevo diventare un piccolo Dahmer… O un curioso osservatore del mondo. Fortunatamente vinse la curiosità.
Mia nonna ci cacciò dalla cucina, aveva da cucinare per sette, ma prima di uscire prendemmo la testa del coniglio.
Cosa rimane
Fu allora che mio padre decise di spiegarmi cos’è la morte — e, soprattutto, cosa ne rimane.
Mettemmo la testa dentro una scatola di latta e la poggiammo sopra la porta del garage.
Ogni settimana, per mesi, aprivamo la scatola per vedere “a che punto era arrivata la scienza”. Mio padre mi spiegava la decomposizione passo dopo passo, fino a quando, un giorno, restò solo lo scheletro bianco.
Ricordo ancora l’ultima volta che abbiamo aperto la scatola: arrugginita, con dentro quello scheletro minuscolo che sembrava guardarmi. Mio padre mi fissò, forse pensando che stessi per piangere, e mi chiese: «Tutto bene?».
Io lo guardai e dissi: «Possiamo tenerlo?».
La risposta fu “no”, non avevamo nemmeno il permesso di toccarlo, però lo ricordo come se avessi ancora quella scatola di latta davanti. Era una scatola della colomba di pasqua, senza nemmeno farlo apposta, con dei conigli sopra e ora anche dentro.
Fu il primo scheletro che vidi, o almeno che mi ricordo, non uno scheletro dentro un piatto, quello faceva parte della realtà “pasto”, questo era uno scheletro messo lì per essere studiato.
«Anche noi abbiamo uno scheletro?»
«Certo, tutti ne abbiamo uno»
«Anche la nonna?»
«Un po’ più bucherellato, ma sì»
«Ah».
di Daniele “Il Rinoceronte” Daccò