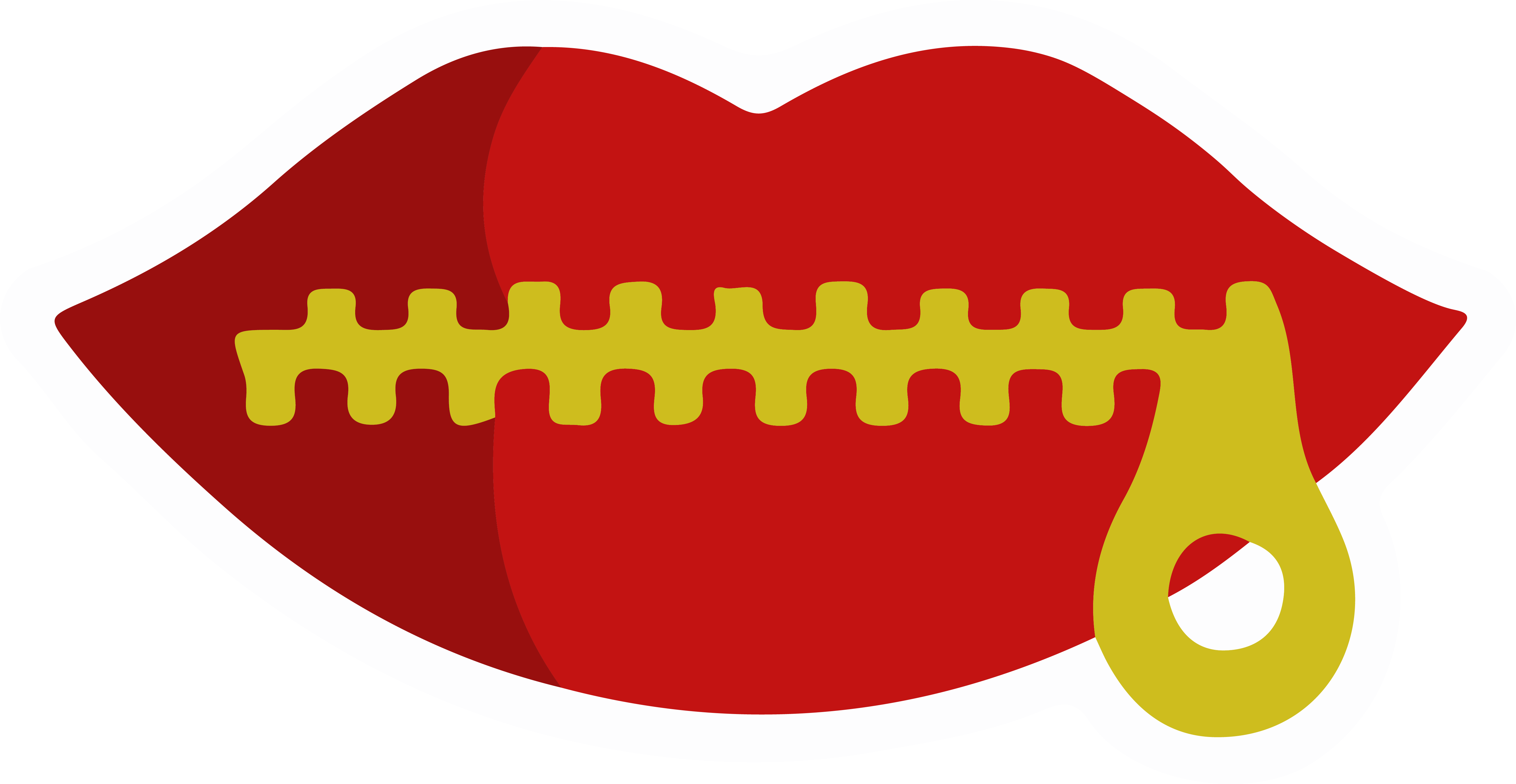Bugia, verità. Bugia, verità. Non sono forse la stessa cosa? Con Bugonia, Yorgos Lanthimos torna al cinema inarrestabile nel suo spietato nichilismo, mettendo in scena un’altra opera magistrale, teatrale, tecnica al punto giusto e minuziosamente esasperante come sempre.
Il cineasta greco costruisce il suo nuovo lavoro sull’ambiguità tra ossessione e realtà che era già presente in Kinds of Kindness, ma che qui si eleva a preoccupazione universale – o che dovrebbe esserlo. Se il film precedente era una trilogia di dipendenze, ossessioni e sottomissioni, Bugonia appare come il seguito naturale del suo secondo episodio: non più un conflitto privato, ma uno scontro tra classi sociali, tra chi esercita il potere e chi ne subisce le conseguenze.
Una matrioska di sistemi (in)umani
La trama è apparentemente semplice: un uomo vede la realtà incrinarsi e nessuno è disposto a credergli. Il cospirazionista e apicoltore amatoriale Teddy Gatz rapisce Michelle Fuller, CEO dell’azienda farmaceutica che con i suoi esperimenti ha portato la madre di Teddy a un coma da cui potrebbe non risvegliarsi mai più. Lo scopo è quello di dimostrare che Michelle, in realtà, è un’aliena proveniente da Andromeda, arrivata sulla Terra con la sua specie per sfruttare gli esseri umani. Riprendendo implicitamente la seconda trama di Kinds of Kindness (con i medesimi Jesse Plemons ed Emma Stone protagonisti), qui Lanthimos mostra come ogni dinamica sociale sia una matrioska, un modello che si replica negli equilibri globali, fino a toccare le forze che regolano la vita stessa.
Eco-ansia e complottismo
Il titolo è chiaro: il riferimento è al mito di Bugonia e della rigenerazione spontanea delle api attraverso la morte e, dunque, l’annullamento. Ma qui le api muoiono. È un disastro annunciato (il film è un remake del più esplicito Save the Green Planet! di Jang Joon-hwan, 2003) eppure nessuno ascolta chi lo vive sulla propria pelle: se in Kinds il protagonista gridava “al lupo” senza essere creduto, qui la rinuncia all’esternazione delle proprie paranoie è immediata e passa per l’esasperazione di un uomo che cercherà di convincere solo se stesso esercitando il poco potere che ha su chi è più debole di lui: il cugino autistico, che è l’unico – debolissimo – legame con l’umanità e unica vera vittima di tutta la faccenda.
Egoismo e delirio
Anche quando la catastrofe diventa plausibile, infatti, il protagonista non agisce per altruismo: il suo motore è sempre egoistico, mosso da traumi e motivazioni del tutto personali, tanto da quasi rinunciare alle proprie convinzioni quando l’ennesima invenzione è convincente abbastanza da fornirgli la soluzione all’unica cosa che realmente lo tormenta. Lanthimos sabota così ogni possibile redenzione e ci spinge a chiederci: che cosa porta davvero l’uomo alla follia? E si è folli quando gli altri non credono a ciò che vediamo, o quando ciò che crediamo diventa indistinguibile dalla realtà?
Bugonia: geometricamente universale
La messa in scena è rigorosa e forse la più “pulita” della carriera di Lanthimos, geometrica nella costruzione delle immagini ma anche nello snodarsi della narrazione, accompagnata nel suo cinismo da esplosioni di comicità sincera e quasi irreale. In questo modo il film rivela la sua capacità di avvicinare anche un pubblico nuovo e poco avvezzo ai cripticismi tipici del regista –in maniera perfettamente coerente con l’universalità della preoccupazione che trasmette.
Bugonia è una favola distopica senza morale, un rituale di follia condivisa in cui vittima e carnefice sono fatti esattamente della stessa crudeltà e dove la bugia, ripetuta abbastanza a lungo, smette di essere tale e diventa realtà.
di Simona Riccio