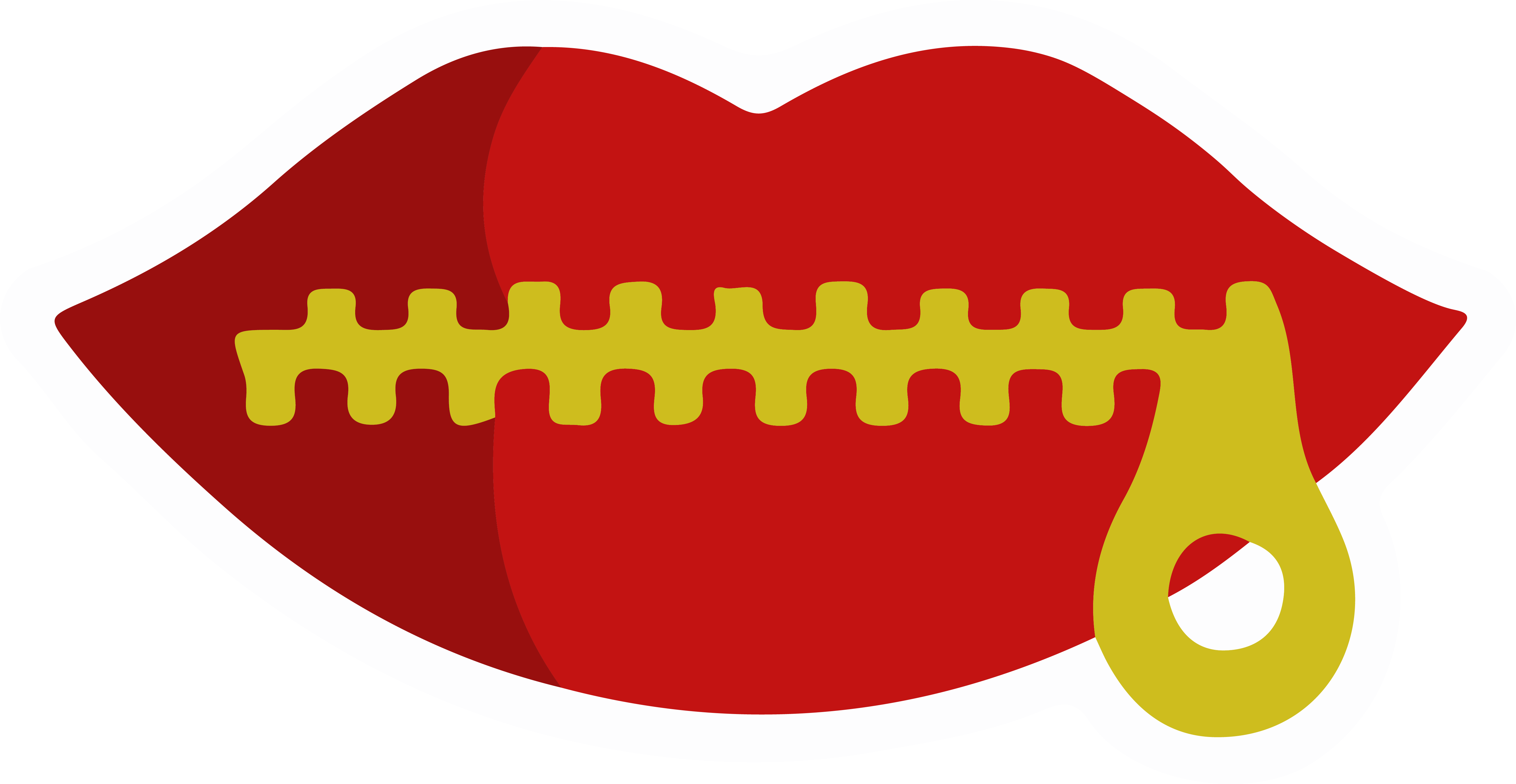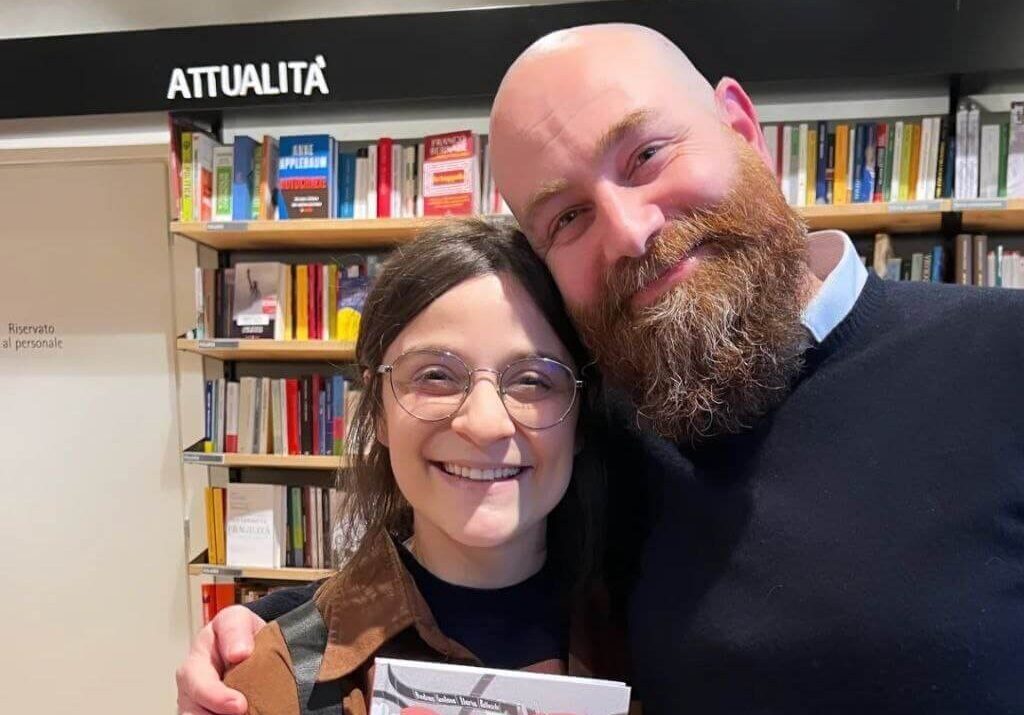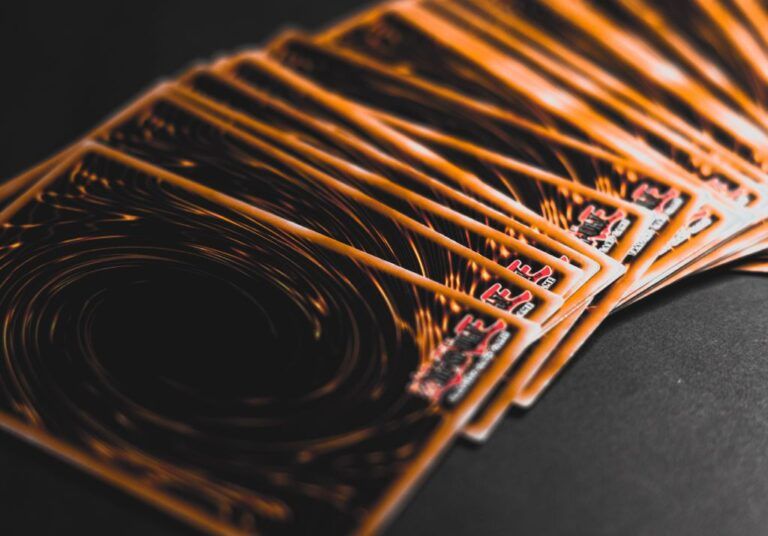Durante la Milano Comics Week di quest’anno ho avuto il piacere di partecipare alla prima edizione di Una città tutta a fumetti, il festival curato da Librerie Feltrinelli con la direzione artistica di Tito Faraci. Quattro giorni intensi, cinque librerie coinvolte e oltre venticinque appuntamenti dedicati al mondo del fumetto: un vero e proprio omaggio alla nona arte. Tra gli incontri più significativi per me, c’è stato quello con Andrea Fontana e Ilaria Palleschi, presenti per raccontare Buster, la loro graphic novel edita da Tunué dedicata a Buster Keaton, uno dei giganti del cinema muto.
Attore, regista e acrobata, Keaton è celebre per il suo volto impassibile, il suo umorismo fisico e la straordinaria inventiva visiva delle sue gag. Un visionario, la cui poetica silenziosa continua ancora oggi a ispirare artisti e cinefili.
Il volume, arricchito dalla prefazione di Maurizio Nichetti, è un omaggio sincero: l’ho trovato un’opera preziosa per sensibilità, intelligenza e stile.
Seguo il lavoro di Andrea Fontana da diversi anni e apprezzo in particolare i saggi sull’animazione giapponese, sempre rigorosi e appassionati. La sua capacità di unire analisi e narrazione trova qui una forma espressiva, perfettamente in sintonia con le tavole di Ilaria Palleschi, che aggiungono profondità visiva ed emotiva al racconto. Vederli lavorare insieme su un progetto così ricco è stata una conferma della loro bravura e della vitalità del fumetto contemporaneo.
Ecco la mia intervista ad Andrea Fontana.
Chi è Andrea Fontana?
La risposta più ovvia è uno scrittore, saggista, critico. Però sono categorie che mi stanno un po’ strette e non mi definiscono. Mi vedo più come un grande appassionato di cose, di cinema, animazione, scrittura.
Poi c’è anche la vita, no? Mi piace pensare di essere qualcosa che va al di là delle cose che scrivo, per quanto importanti siano e abbiano un ruolo fondamentale nella mia vita. Il mio privato ha un ruolo principale, non lo si ricorda mai abbastanza, si tende sempre in generale a celebrare l’opera ma ci si dimentica che magari che dietro l’opera c’è un aspetto umano altrettanto importante.

C’è stato un momento preciso, un evento determinante, che ha segnato l’inizio della tua passione e che poi ti ha spinto a trasformarla in un vero e proprio percorso professionale?
Ricordo di essermi innamorato del cinema fin da piccolo. Non c’è stata una spinta familiare, né un’influenza esterna che mi abbia indirizzato: non era ancora quell’ossessione che poi sarebbe diventata per me. È stato piuttosto un innamoramento naturale, nato spontaneamente e cresciuto con il tempo. Col passare degli anni, man mano che acquisivo gli strumenti mentali e concettuali per interpretare ciò che vedevo, questo amore si è trasformato. Mentre la mia vita proseguiva, riuscivo a collegare nuove idee, ad aggiungere tasselli, e a poco a poco il cinema è diventato qualcosa di più profondo, più radicato: non più solo una passione, ma una parte essenziale di me.
Per quanto riguarda l’animazione, credo che il mio legame profondo con questo mondo sia nato dal fatto di appartenere a una generazione cresciuta negli anni ’80, quando l’animazione giapponese iniziava a entrare prepotentemente nelle case degli italiani grazie alle emittenti televisive regionali. Per noi rappresentava una vera e propria rivoluzione: qualcosa di completamente nuovo, mai visto prima. Eravamo abituati solo all’animazione Disney che per quanto bella e interessante era l’unica cosa opposta ad Hanna-Barbera o i Looney Tunes. Quella giapponese proponeva un tipo di animazione differente, vi erano dei concetti che andavano ben oltre a quelli classici etico-morali dell’animazione occidentale.
Ti va di parlami dell’idea che c’è dietro la creazione di Buster? Cosa ti ha portato a voler realizzare questo progetto? Cosa speri che i lettori pensino una volta finito di leggere quest’opera?
In primo luogo anch’io conoscevo poco della vita privata di Buster Keaton. Lo avevo sempre ammirato soprattutto come autore, come genio del cinema. L’ho adorato per il suo lavoro. Ma realizzare un’opera che si limitasse a celebrare il suo cinema sarebbe stato, in fondo, un esercizio un po’ fine a sé stesso.
Quello che mi ha davvero interessato è stato affrontare gli aspetti più nascosti, quelli meno raccontati, della sua esistenza. È molto più stimolante e, a mio avviso, significativo, raccontare il lato umano di figure di questo calibro.
Situazioni drammatiche in cui si ritrovarono questi grandi personaggi che hanno segnato la storia del cinema, non te lo aspetteresti per un divo qualsiasi di Hollywood al giorni d’oggi.
Secondariamente, la parte che mi intrigava era legata al linguaggio del fumetto. Come faccio a intersecare degli elementi puramente cinematografici e altri fortemente umani all’interno di una narrazione a fumetti? Creare quest’opera rappresentava una tripla sfida che ho voluto affrontare e spero di esserci riuscito.
La difficoltà era riuscire a riposizionare Buster Keaton all’interno di un contesto narrativo che fosse accessibile anche e soprattutto per coloro che non lo conoscono. Il fatto che in molte presentazioni in cui mi sono trovato a parlare del libro in tanti mi dicessero “Sai, non conoscevo Buster Keaton e dopo aver letto la vostra opera mi viene voglia di andare a vedere i suoi film!”, è una cosa molto positiva e che fa molto piacere sentire.
Credo di aver dato un contributo importante ad una figura che ha lavorato più di 100 anni fa e mi è sembrato giusto doverlo ricordare.
Di recente hai pubblicato una nuovo saggio, Robert Zemeckis – Il tempo, l’immagine, lo sguardo, edito da WeirdBook. Cosa puoi dirmi al riguardo?
L’idea è nata dalle ceneri di un libro che avevo pubblicato diversi anni fa. All’epoca avevo scelto di strutturarlo per temi, individuando una serie di concetti chiave ricorrenti nel cinema di Zemeckis e analizzando trasversalmente le sue opere attraverso questi nuclei tematici. Questo approccio mi aveva colpito in modo particolare leggendo una monografia di Serge Grünberg dedicata a David Cronenberg, e fu proprio quell’ispirazione a spingermi a realizzare un testo seguendo una metodologia simile.
Nel frattempo sono passati molti anni, Zemeckis ha realizzato numerosi film ed è gradualmente uscito dal centro dell’attenzione più generalista. Mi è sembrato quindi naturale tornare sui miei passi e ripensare quel libro, ristrutturandolo in una forma più lineare e cronologica. Il volume è ora suddiviso in capitoli, ognuno dedicato a un singolo film della sua carriera, fino all’opera più recente, Here.
Zemeckis pur rimanendo sempre coerente con sé stesso ha comunque cambiato molto del suo cinema e probabilmente è cambiato anche il modo in cui il pubblico si relaziona al suo lavoro. È sempre stato un autore molto seguito, quasi alla pari di Spielberg, con ogni suo progetto accolto da grande attenzione.
Tuttavia, a un certo punto, qualcosa è cambiato. Non è stato lui a cambiare, ma il cinema, e con esso il mondo.
Ponendo brevemente l’accento sul suo ultimo film – il già citato Here, bellissimo – vi consiglio di leggere la graphic novel di Richard McGuire da cui è tratto. Questa pellicola è molto testamentaria, perché racconta della nascita, vita, morte. Un film in cui il regista fa i conti con il suo stesso cinema e che sperimenta moltissimo. La cosa interessante è che questo film non è stato per niente capito. Negli Stati Uniti lo hanno boicottato in tutti i modi, la critica non ha nemmeno provato a fare un approfondimento in merito. Questo secondo me sottolinea molto la distanza fra la critica europea e quella americana.
Zemeckis secondo me è un grande della storia del cinema ed è ovvio che ci ha dato film che sono rimasti nell’immaginario collettivo: Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit?, Forrest Gump, eccetera, però quello che mi interessava affrontare in questo libro era riuscire ad identificare tutto il fil rouge che va a comporre il cuore concettuale della sua produzione. È vero che lui dice sempre “Io non sono un autore, io sono un regista che vuole far film commerciali”, però mente a sé stesso perché se vai ad analizzarlo il suo è un cinema fortemente autoriale.
Ci sono delle tracce evidenti, nel suo cinema, di una serie di temi: il tempo, la memoria, la storia. Here è un altro modo, come lo era Forrest Gump, per affrontare l’evoluzione della società della storia americana.
Andrea, che cosa ti lascia senza Niente Da Dire?
Questa è una domanda difficilissima.
Quando non c’è niente da dire, vuol dire che non c’è niente d’interessante. Nella mia esperienza professionale, io tendo sempre a parlare delle cose che mi interessano, che mi ispirano, che mi provocano una riflessione. Quando non parlo di qualcosa evidentemente è perché quella non è interessante.
Però credo anche che per i tempi in cui viviamo è importante che ci sia qualcosa da dire. Si deve parlare, anche delle cose più scomode e soprattutto che si parli di cose che portino a riflettere.
di Federica Curcio